LA POETICA DI GIORGIO CAPRONI
C’è una poesia di Giorgio Caproni paradigmatica dalla quale converrà prendere le mosse nel presente scritto, intitolata Battendo a macchina: “Mia mano, fatti piuma:/ fatti vela; e leggera/ muovendoti sulla tastiera,/ sii cauta. E bada, prima/ di fermare la rima,/ che stai scrivendo d’una/ che fu viva e fu vera…”; più che sufficiente davvero, tale poesia, grazie a questa sua prima strofe (inclusa nei Versi livornesi, all’interno dalla raccolta IL SEME DEL PIANGERE, 1959) per comprendere il difficile e felice equilibrio tra spirito aristocratico e vena popolare raggiunto in modo esemplare da Caproni con la suddetta raccolta; per diversi studiosi il frutto più fine della sua storia poetica (e basterà citare al riguardo nomi come quelli di Biancamaria Frabotta e Pier Vincenzo Mengaldo; quest’ultimo prefatore del Meridiano Mondadori dedicato al poeta). Difficile se non impossibile, naturalmente, negare la grazia affilata della poesia di Giorgio Caproni fino all’acme del SEME DEL PIANGERE, dagli esordi genovesi influenzati dalle correnti ermetiche e, in particolare, dalla presenza tutelare e costante di Camillo Sbarbaro. Del resto non andranno dimenticati, del nostro poeta (nato a Livorno nel 1912), i notevoli sonetti “monoblocco” inclusi nel PASSAGGIO D’ENEA (raccolta del 1956) fra i quali spicca per chi scrive Alba (1945), con endecasillabi tronchi in uscita non vocalica rafforzati da interiezioni sapienti ( a frantumare la musica consolidata di una forma dorata e “chiusa” della nostra grande tradizione letteraria). In ogni caso anche il peso del PASSAGGIO D’ENEA risulta evidente, nello sviluppo del lavoro poetico del grande Livornese, alludendo alle famose e bellissime Stanze della funicolare leggibili in tale raccolta. Sarà bene a questo punto rammentare – volendo giungere al cuore di quanto mi preme sottolineare più avanti su Caproni- la finissima attività di traduttore del poeta, ripensando soprattutto ai suoi Proust, Céline, per tacer d’altri; giacché tale attività ha dischiuso ovviamente al grande Livornese, per sua stessa ammissione, lungo il corso degli anni, “zone” dell’affettività e della cognizione altrimenti insondate. Ma eccoci al punto: i lettori che amano il nostro poeta, e sono in molti, sanno di una innegabile, rilevante cesura fra un “primo” Caproni e un “secondo” Caproni, per così dire; cesura sulla quale sarà necessario insistere qui proprio per tentare di comprendere le ragioni di una voce poetica più che mai viva e incisiva nei tempi attuali. Così dicendo, ecco che non possiamo non individuare nel CONGEDO DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO & ALTRE PROSOPOPEE (1965), la suddetta cesura fra quanto precedentemente pubblicato da Caproni e la grande Trilogia compresa fra gli anni Settanta e Ottanta (IL MURO DELLA TERRA, 1975; IL FRANCO CACCIATORE, 1982; e IL CONTE DI KEVENHŨLLER, 1986). Basterà, in merito, rileggere la chiusa della poesia che dà il titolo alla citata raccolta del 1965 (dedicata all’attore Achille Millo): “Ora che più forte sento/ stridere il freno, vi lascio/ davvero, amici. Addio./ Di questo, sono certo: io/ son giunto alla disperazione/ calma, senza sgomento./ Scendo. Buon proseguimento”. Non posso negare, per quanto mi riguarda, di nutrire un sentimento quasi di devozione per tali versi: essi, infatti, nella loro disarmante semplicità, si fanno profondissima metafora della condizione umana; talché, a questo punto, la voce di Caproni conquista maggiore libertà tematica e formale rispetto alle precedenti e pur splendide prove (il pensiero torna, soprattutto, ai citati Versi livornesi del SEME DEL PIANGERE e dedicati ad Anna Picchi, ricamatrice e suonatrice di chitarra, madre del poeta; poeta-violinista, questi, peraltro, diplomato in composizione giovanissimo a Genova). Sia come sia, con il CONGEDO del 1965 (l’anno di un traumatico intervento operatorio per il poeta, che da allora fino alla morte vivrà da “resecato gastrico”, per sua stessa definizione); sia come sia, stavamo dicendo, col CONGEDO, comincia il “viaggio metafisico” di Giorgio Caproni, in tutta evidenza. Il grandissimo cantore di Genova, sua città d’adozione, e della madre- fidanzata del poeta (che intuizione, quella di cantare la giovinezza materna!); cantore nel contempo antico e sottilmente sabotatore come già detto, della nostra grande tradizione metrico-stilistica; questo cantore, insomma, col CONGEDO, scopre le sue carte decisive di “cerimonioso dicitore del nulla”, secondo quanto osservato da Italo Calvino (e non a caso il grande Livornese è stato accostato a Samuel Beckett). Il nostro poeta, austero e riservato, maestro elementare per tutta la vita, parlerà in effetti con la sua voce più alta nel 1975, dando alle stampe IL MURO DELLA TERRA, accolto con grande favore di critica e di pubblico. Con il MURO, infatti, tutto è mirabilmente al suo posto; nel senso che nel libro la densità metafisica di una evidente “ontologia negativa” (sempre per citare Calvino), è una cosa sola con una forma “frantumata e ellittica” (com’è stato osservato da più parti); la cui qualità più corrosiva, forse, consiste nella chiusa delle poesie: senza punti di domanda che possano favorire un rassicurante dialogo con il lettore. Detta qualità di Caproni, è stata individuata felicemente da Carlo Bo; senza stupirsene più di tanto da parte nostra; ché, in tutta evidenza, Carlo Bo ha avvicinato i grandi poeti del Novecento italiano più intensamente di altri; nel senso umano del termine, prima ancora che dal punto di vista strettamente critico. Ma torniamo a Giorgio Caproni. Dopo IL FRANCO CACCIATORE del 1982 -laddove si può percepire un certo “manierismo” rispetto al libro precedente, come osserva a parer mio giustamente Pier Vincenzo Mengaldo in antitesi, nella fattispecie, agli eccessivi entusiasmi di Pietro Citati- eccoci al cospetto dell’ultimo grande libro di Caproni: IL CONTE DI KEVENHŨLLER, del 1986. Con tale raccolta la poesia di Caproni raggiunge una stoica, rarefatta scansione; con alte e attualissime punte di agnizione nell’indicarci l’inquietante ambivalenza fra l’Essere e il Nulla: quasi il poeta si fosse dotato di un misterioso periscopio grazie al quale scrutare la scaturigine tutt’altro che rassicurante di tutti gli ossimori, di tutte le ambiguità (senza dare cioè l’impressione di una pratica letteraria e forzata dei contrari, ossia a posteriori). Così, nel CONTE DI KEVENHŨLLER, il cacciatore è la sua preda; la Bestia, per la cui uccisione il Conte ha promesso bei soldoni alla popolazione, è sfuggevole e parte di noi; e si potrebbe continuare a lungo. Il poeta morì il 22 gennaio 1990; sul comodino (è stato riferito) la pagina della COMMEDIA laddove spiccano i famosi versi: “L’alba vinceva l’ora mattutina/ che fuggia innanzi, sì che di lontano/ conobbi il tremolar de la marina”; Purg. I, 115-7: il giorno successivo, 23 gennaio, il suo funerale, senza la presenza delle autorità (nel quartiere romano di Monteverde, dove abitava); in perfetto stile con la riservatezza e il distacco del grande Livornese, si potrebbe chiosare con amara asciuttezza (non mancarono però Walter Binni, Biancamaria Frabotta e Valerio Magrelli). D’altronde la poesia di Giorgio Caproni costituisce un patrimonio ricchissimo e attuale della mente e del cuore di numerosi lettori; e di chi scrive in modo particolare -mi sia concesso di dire- avendo io abitato dal 1969 al 1980 a trecento metri dal grande Livornese, nella piazza dove sbocca la salita di via Pio Foà (via lungo la quale, dal 2012- in occasione del centenario della nascita di Caproni- è visibile al numero 28 una targa che lo ricorda, assieme ai versi di Dopo la notizia, dal MURO DELLA TERRA). Mi piace concludere questo scritto citando di Caproni i versi in morte di Pasolini, suo grande amico (intitolati Dopo aver rifiutato un pubblico commento sulla morte di Pier Paolo Pasolini , ora inclusi nella raccolta postuma RES AMISSA, 1991, curata da Giorgio Agamben): “Caro Pier Paolo./ Il bene che ci volevamo/ -lo sai- era puro./ E puro è il mio dolore./ Non voglio pubblicizzarlo./ Non voglio, per farmi bello,/ fregiarmi della tua morte/ come d’un fiore all’occhiello.” Così era Giorgio Caproni, maestro elementare fino al 1973: un uomo riservato e fiero che insegnava ai suoi alunni invogliandoli a scrivere versi; non negandosi neppure a scuola la gioia del trenino elettrico.
Andrea Mariotti, 9 aprile 2015
P.S. Ripropongo qui il mio scritto relativo al grande poeta apparso nella suddetta data sul presente blog e incluso nel n.61 della rivista letteraria I Fiori del Male, maggio agosto 2015 (a/m)
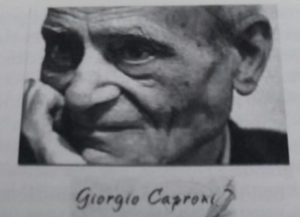
Ho letto con attenzione, Andrea, il tuo scritto ampio ed articolato su Giorgio Caproni, grande, indimenticato poeta del secondo Novecento italiano. Mi piace qui ricordarLo anche come straordinario maestro elementare che amava insegnare (i suoi metodi didattici erano innovativi e rivoluzionari per i tempi) e “imparare” dai suoi allievi, a lui molto cari, dai quali era adorato per le sue doti di umanità, di pazienza, di ironia e per quella sensibilità -rara- di toccare la loro anima.”Era quasi un fratello maggiore per i suoi alunni” scrive Vincenzo Cerami.”…faceva studiare loro le poesie a memoria, ma non disse mai di essere lui stesso un poeta”. Esempio luminoso di uomo ,oltre che “poeta del sole, della luce e del mare”, come Giorgio Caproni e’ stato definito da Carlo Bo.
Spesso vedevo Vincenzo Cerami, Fiorella, nei miei anni “monteverdini”, in via Pio Foà in visita al poeta…hai fatto bene a ricordare le sue parole riguardanti il grande Livornese, e ancor meglio hai fatto nel rammentare quelle di un critico insigne come Carlo Bo.